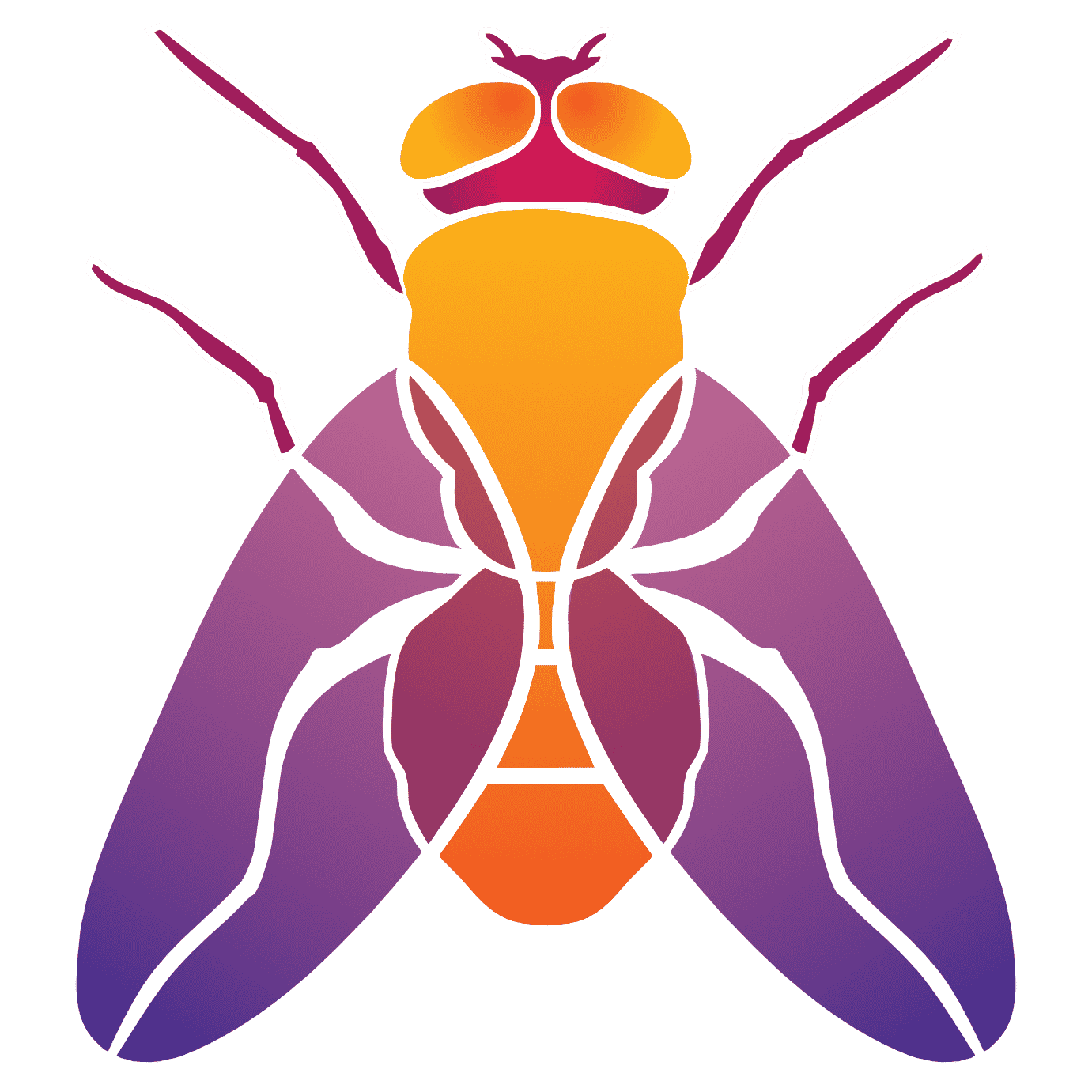“Stati Uniti, anni Ottanta: Maren, una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, incontra Lee, un vagabondo dai sentimenti profondi. I due iniziano un viaggio nella remota provincia americana, scoprendo sempre di più se stessi e ciò che il futuro ha in serbo per loro.“

Dopo “Chiamami col tuo nome” (“Call me by your name“, 2017), un teen-drama a sfondo romantico, e “Suspiria” (2018), remake del celebre horror di Dario Argento, il regista siciliano Luca Guadagnino con “Bones and All” (2022), suo settimo lungometraggio, sceglie di far “incontrare” i tre generi delle due precedenti pellicole, il coming-of age, il melodramma, e l’horror appunto, prendendo come spunto l’omonimo romanzo della scrittrice Camille DeAngelis, ambientato nell’America reaganiana degli anni Ottanta.
I due giovanissimi protagonisti, Maren e Lee (interpretati, rispettivamente, da Taylor Russell e Thimothèe Chalamet, entrambi in grande spolvero) sono condannati all’emarginazione sociale, a causa delle loro pulsioni cannibali, ed entrambi sono alla ricerca di un loro posto nel mondo: la prima, dopo essere stata abbandonata dal padre, si mette alla ricerca della perduta madre (da cui potrebbe avere ereditato la sua “condizione”), percorrendo un lungo viaggio nell’America più profonda e misteriosa, mentre il secondo vive secondo le sue regole, scappando di casa e vivendo “alla giornata”, sfruttando le opportunità che gli si parano davanti, come il più classico dei ribelli senza causa, ma perseguitato anch’egli dalla condizione cannibalistica. Tra di loro, quando si incontreranno, ci sarà subito del tenero, inevitabilmente…
“Bones and All” non è un’opera “originale” nella sostanza (nelle tematiche che tratta e nell’articolazione dei tòpoi narrativi dei diversi generi, che risultano “già visti”), ma è nobilitato da una forma (la cifra stilistica di Guadagnino, che sta divenendo sempre più riconoscibile, film dopo film) che riesce a rendere il risultato finale perfettamente bilanciato, in cui il melò, il road-movie, e il thriller-splatter, non prevalgono mai l’uno sull’altro (meglio: nessuno mangia l’altro, per collegarsi al cannibalismo del film…) ma sono cesellati con ottima maestria dal regista di Palermo, che riesce a rendere la sua opera sempre interessante e coinvolgente per tutte le due ore in cui si dipana la vicenda.
Maren e Lee fanno di tutto per sfuggire alla loro condizione patologica, per tentare di vivere una vita il più possibile normale, di comportarsi come una giovane coppia di innamorati della loro età, ma il loro destino è segnato in partenza, condannati da un lato a fare i conti con un tragico passato (Maren e l’incontro con la madre, rinchiusa in manicomio, e Lee, che ha ucciso il padre), e dall’altro dall’inevitabile esclusione sociale a causa della loro “diversità” (sia Maren che Lee sono costretti a scappare continuamente da un posto all’altro, per evitare di essere perseguitati dalla gente “normale”). Lo stesso regista ha definito la pellicola come “una fiaba sulla solitudine dell’esistere, e contemporaneamente su come spezzare questa solitudine attraverso l’essere guardati da un altro. Un’opera che affronta in maniera diretta il tema della solitudine.“
I due giovani sono costretti all’emarginazione da una società che non gli comprende, e anzi gli ripudia: ed è quello che accade anche ai loro “simili”, che incontrano durante il viaggio, su tutti il vecchio Sully (interpretato da un superlativo Mark Rylance), che Maren incontra all’inizio della sua avventura, il quale invita la giovane a casa sua, facendole addirittura consumare un “pasto” insieme a lui. Sully ha sviluppato un “olfatto sovraumano” in grado di riconoscere gli altri cannibali e anche di individuare le persone che stanno per morire, così da non “uccidere” nessuno e non sentirsi in colpa per quello che deve inevitabilmente fare…Prova quantomeno a rendere più “umana” la sua condizione con questo compromesso, ma anche lui è una persona sola, che vive nelle case occupate della gente che ha mangiato, fino a che non gli viene di nuovo fame…
L’America che Guadagnino ritrae nel suo film è l’altro lato della medaglia del “sogno americano”, quella di chi si trova nell’ultimo gradino della piramide sociale, di chi parte da una posizione di svantaggio rispetto agli altri, e che non riesce a trovare il suo posto nel mondo, per altro in un decennio (quello degli anni Ottanta di Ronald Reagan) votato all’esaltazione dell’individualismo più sfrenato. E non è ovviamente un caso che sempre in questo decennio negli USA si ebbe un boom di malati e morti di AIDS, a cui la condizione di cannibalismo del film può essere una chiara ispirazione, con annesse le conseguenti emarginazioni di chi era affetto da questa patologia.
Nel complesso, una delle opere più riuscite di Guadagnino, che ricalca molti dei temi già cari ai cineasti della “Nuova Hollywood” degli anni Sessanta/Settanta, ma sempre mantenendo un personalissimo sguardo verso un mondo e un’ epoca di grandi cambiamenti sociali e culturali, senza mai scivolare nell’abusato citazionismo che oggi circonda il decennio Ottanta, riuscendo a realizzare un’emozionante, ma mai “smielata”, storia d’amore e morte: Eros e Thanatos, più che mai così legati.