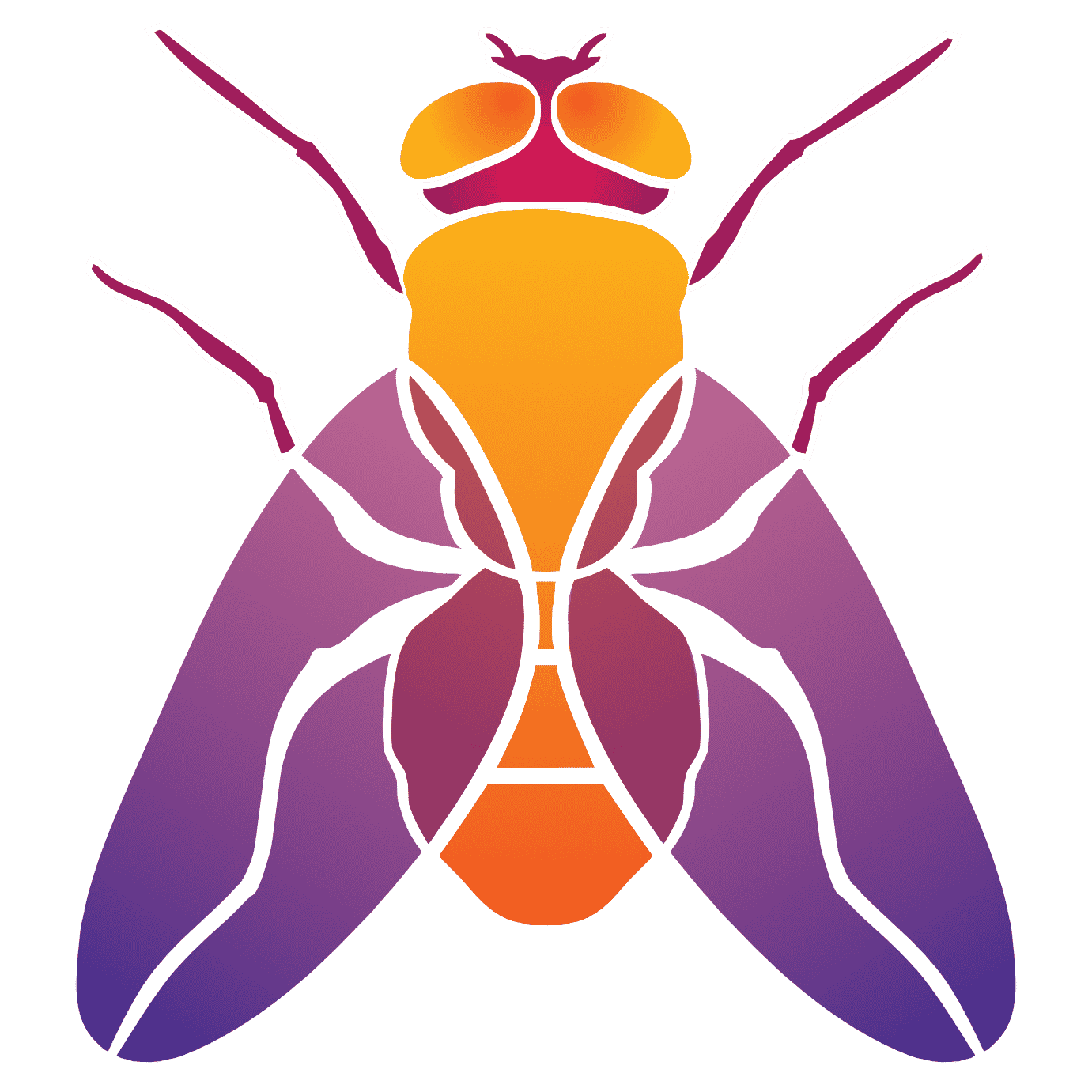“Oltre un decennio dopo gli eventi del primo film, Jake Sully è ormai il capo della tribù dei Na’vi della foresta, e con la sua compagna Neytiri hanno avuto tre figli, oltre ad averne adottata un’altra: tutto sembra andare per il meglio, fino a quando gli umani fanno ritorno su Pandora per vendicarsi, costringendo Jake e la sua famiglia a trovare rifugio da un’altra tribù, che vive a stretto contatto con il mare“

Per uno come James Cameron il tempo non sembra minimamente passato: il suo “Avatar” (2009) rivisto oggi a 13 anni di distanza conserva perfettamente tutta la sua forza spettacolare, con il termine “spettacolo” inteso nel suo senso più puro, ovvero di una “visione capace di emozionare”, in questo caso tramite una messa in scena davvero rivoluzionaria (allora come oggi), capace di dare un senso alla tecnologia 3D, come un’ estensione delle possibilità artistiche del cinema.
E proprio 13 anni sono passati per vedere finalmente l’uscita nelle sale del secondo capitolo della saga (dopo innumerevoli rinvii causa problematiche produttive), “Avatar-La via dell’acqua“, ma d’altronde da un perfezionista assoluto come Cameron c’era da aspettarselo, ossessionato (come solo i grandi autori sanno essere) dalla riuscita assoluta di ogni singolo fotogramma e dalla sperimentazione di nuove tecniche di ripresa (la maggior parte delle scene sono state effettivamente girate sott’acqua, così da ottenere nella recitazione degli attori un effetto maggiormente “realistico” durante le innumerevoli sequenze sottomarine).
Cameron è tornato in quello che probabilmente è il suo “habitat naturale preferito”, il mare, già “protagonista” di altri due suoi lavori precedenti, il più che celebre “Titanic” (1997) e soprattutto “The Abyss” (1989), ambientato (come suggerito dal titolo) nelle profondità abissali: sia per la lavorazione travagliata, che per le innovazioni tecnologiche improntate da Cameron (venne girato quasi interamente in un vero laboratorio in fondo all’oceano), oltre che per la presenza nella vicenda di forme di vita aliene sottomarine, per certi versi “The Abyss” si può quasi considerare il “seme” del sequel di Avatar.
Anche Avatar 2 si svolge decenni successivi agli eventi narrati dal primo film, in cui ormai l’ex-marine Jake Sully (Sam Worthington) è divenuto il più forte e rispettato dei guerrieri Na’vi della foresta, ha messo su famiglia con la principessa Neytiri (Zoe Saldana), che gli ha donato tre figli (Neteyam, Lo’ak, Tuk), oltre ad averne adottata una quarta, Kiri, concepita dal defunto Avatar della scienziata Grace Augustine (interpretata da Sigourney Weaver, che in questo film veste i panni proprio di “sua figlia” Kiri…). Oltre a loro, la coppia si occupa anche di un ragazzino umano, Spider, figlio del colonnello Miles Quaritch (Stephen Lang, il villain della saga), che è stato abbandonato dagli uomini durante la loro fuga forzata da Pandora: minaccia che però ritorna prepotentemente, colonnello compreso (ora “trasformato” in un Na’vi), e che costringe Jake e la sua famiglia a darsi alla fuga, trovando rifugio in una nuova tribù, i Metkayina, che vive in simbiosi con il mare, e in cui i nostri protagonisti dovranno cercare di integrarsi…
Oltre al già menzionato ambiente marino, i principali protagonisti di questo secondo capitolo non sono come si potrebbe pensare Jake e Neytiri, che hanno avuto il loro grande e approfondito spazio nel primo film, ma sono i cinque ragazzi sopracitati ad essere il vero fulcro della storia: se nel 2009 Cameron non ha fatto altro che prendere lo stereotipo narrativo dello straniero che entra in contatto con una popolazione indigena (in questo caso aliena), inizialmente con intenti “distruttivi” (convincere i “selvaggi” a lasciare la loro terra, con le buone o con le cattive) per poi fraternizzarci e stare dalla loro parte (es: “Balla coi Lupi” (1990) di Kevin Costner, “Antonio das Mortes” (1969) di Glauber Rocha, “Pocahontas” (1995) della Disney ecc…), in questo sequel la storia si concentra quasi totalmente sul rapporto tra genitori e figli, e sulla crescita di questi ultimi in un mondo dominato da violenza e diffidenze, in cui il passaggio all’età adulta è quasi immediato, e per questo traumatico.
Lo’ak, uno dei tre figli, è il più classico degli adolescenti ribelli in apparenza (non è disposto a seguire alla lettera le ferree regole impostegli dal padre) ma in realtà è fragile e bisognoso di affetto, che il severo padre però sembra non corrispondergli come dovrebbe, mentre Kiri, la figlia adottiva, è una bambina “speciale”, in quanto sembra avere una particolare connessione con la natura di Pandora, come se sentisse che il pianeta stesso stia “comunicando con lei”, anche se questo “dono” ha l’effetto collaterale di causargli crisi epilettiche: entrambi sono vittima di incomprensioni, se non di veri e propri episodi di discriminazione, come quando i figli del capo tribù dei Metkayina gli prendono in giro per la loro natura di “mezzosangue” (metà umani e metà Na’vi).
Il caso più interessante è però quello di Spider, il figlio del colonnello che, pur essendo umano, rifiuta la sua natura biologica e si comporta esattamente come un Na’vi, muovendosi e parlando come uno di loro: quando il redivivo Miles Quaritch lo cattura, questi prova a ristabilire col figlio ritrovato e riconosciuto un legame affettivo che, oltre alle sincere buone intenzioni, gli serve anche per tentare di farlo passare dalla propria parte: inizialmente riluttante, più avanti Spider insegnerà al suo vero padre la cultura Na’vi (dato che ormai si ritrova nel “corpo del nemico” che aveva combattuto in passato), stabilendo con lui un minimo rapporto di fiducia, ma rifiutando comunque di sentirsi effettivamente appartenente alla sua “vecchia razza”, vista la troppa crudeltà del colonnello nei confronti della sua “razza adottiva”. Cameron ha parlato di questo film paragonandolo alla saga del “Padrino“, affermando che “si tratta di una saga familiare generazionale (…) in cui ora sono i ragazzi ad avere in mano il loro futuro“.
In “Avatar-La via dell’acqua” comunque è la natura a prendersi la ribalta, e non solo dal punto di vista scenico, ma anche narrativo: uno dei protagonisti del film è infatti una creatura marina del luogo, chiamato Payakan, appartenente alla specie dei Tulkun, l’equivalente della balena nel nostro mondo. Questo animale, che nel film viene detto essere molto più intelligente degli stessi uomini, ha un ruolo fondamentale nella pellicola, essendo colui che prima salva la vita a Lo’ak, facendoci amicizia dopo che stava per essere divorato da un mostro marino simil-squalo, per poi salvarla agli altri Na’vi, quando un suo intervento è decisivo nella battaglia contro i militari invasori. Payakan è un incompreso, accusato ingiustamente dai Metkayina di avere ucciso degli umani (cosa proibita tra gli esemplari della sua specie), e soltanto Lo’ak (anch’esso un incompreso, non a caso) capisce che in realtà è innocente, sviluppando un legame speciale con il gigantesco tulkun, che nella parte finale avrà comunque la sua “redenzione”.
Al di là di ogni discorso sulla trama e sui sottotesti presenti (è più che evidente come nel primo capitolo la presa di posizione ecologista del regista), quello che inevitabilmente affascina de “La via dell’acqua” (come per il suo predecessore) è la costruzione visiva di questa natura: ed è qui che entra in gioco il 3D, utilizzato da Cameron per amplificare ulteriormente la straordinaria potenza visiva delle sue immagini, che ci (di)mostrano quanto può essere bello sentirsi così vicini verso un mondo virtuale così simile al nostro.
Nella seconda parte del film, quella in cui i figli di Jake e Neytiri per accelerare il loro processo di integrazione devono imparare a nuotare sott’acqua il più a lungo possibile, è l’ideale pretesto per mostrarci finalmente le meraviglie di questo piccolo/grande mondo subacqueo: Cameron filma tutte le scene sottomarine come se fosse un documentarista del “National Geographic” (ed è un pregio questo) che sta esplorando un ambiente a lui sconosciuto con gli occhi di un adolescente (i veri protagonisti di questo sequel, come detto), abbandonandosi alla contemplazione e rallentando il ritmo della narrazione, lasciando agli occhi dello spettatore il godimento dello spettacolo che, come detto nell’introduzione, è sinonimo di emozione.
Cameron è un regista “classico” (uno degli ultimi rimasti in circolazione) catapultato nel cinema iper-moderno contemporaneo, per cui ancora vale la sempreverde regola che “la forma non abbellisce il contenuto, lo crea“: così affermavano Eric Rohmer e Claude Chabrol parlando del cinema di Alfred Hitchcock, e il discorso per il regista canadese non cambia, anzi si rafforza. Non sappiamo se “Avatar 2” salverà definitivamente le sale cinematografiche (al momento ha incassato 2 miliardi di dollari), ma sicuramente ha dimostrato ancora una volta di più che l’esperienza di visione al cinema, quando si ha a che fare con opere come questa, è unica e insostituibile. Aspettando i prossimi 3 capitoli, con rinnovato entusiasmo.