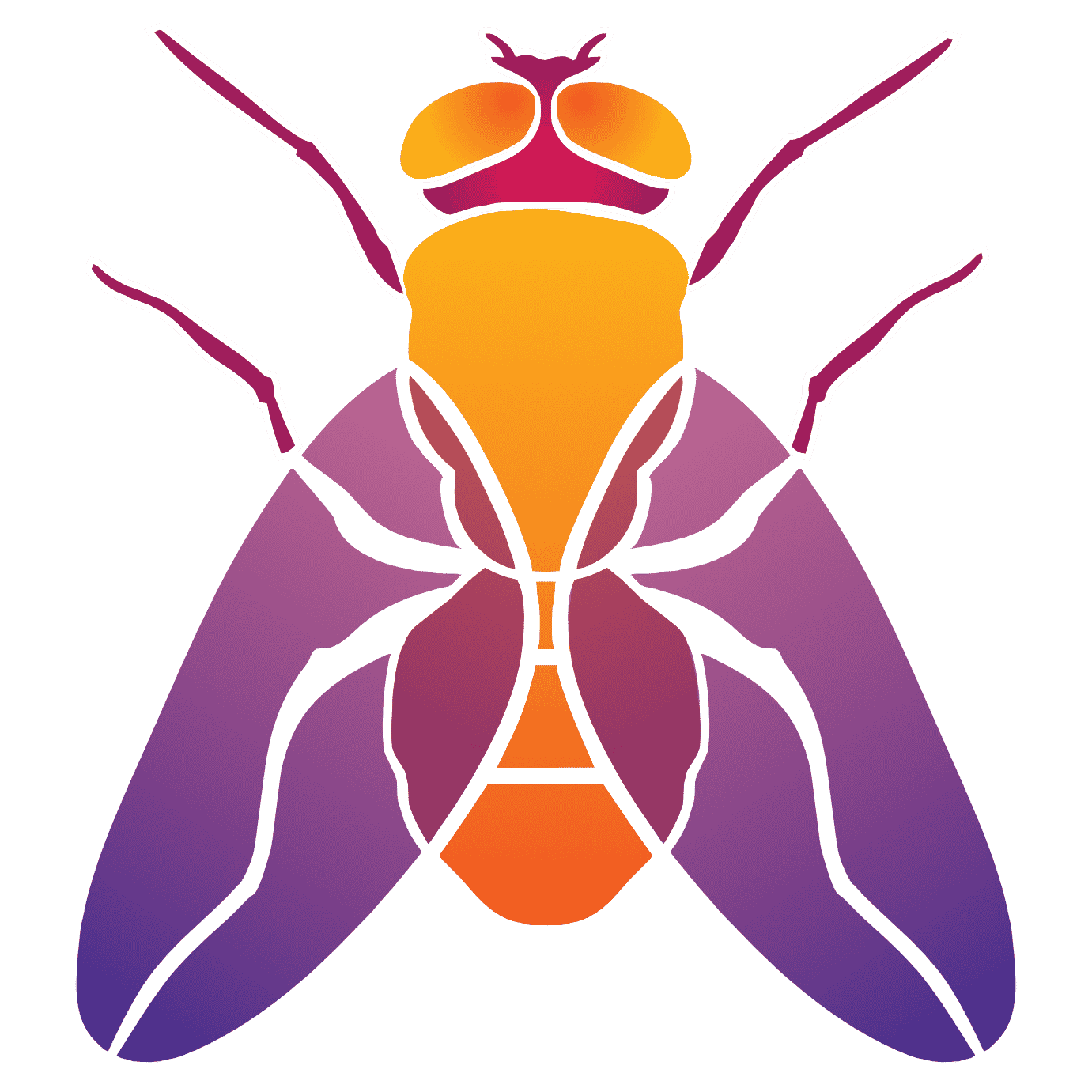“Anni Venti del Novecento: nella contea di Osage, in Oklahoma, sono stati scoperti diversi giacimenti di petrolio e parallelamente si sono verificati una serie di omicidi, aventi come vittime alcuni cittadini facoltosi della tribù indiana locale. L’FBI avvia così un’indagine sui decessi sempre più sospetti.”

“Il più grande regista vivente“: queste le esatte parole con cui il grande regista italoamericano Francis Ford Coppola ha definito Martin Scorsese, subito dopo aver ultimato la visione dell’ultimo lavoro dell’amico/collega, “Killers of the Flower Moon”, uscito anche nelle sale italiane giovedì 19 ottobre, dopo essere stato presentato (fuori concorso) allo scorso Festival di Cannes.
Non si perderà certo tempo in questa sede ha dibattere sui fondamenti dell’affermazione del buon Coppola, essendo pur sempre un opinione personale e come tale discutibile a priori. Quello che invece non si può (oggettivamente) mettere anche solo in discussione, è che il signor Scorsese (classe 1942) sia UNO dei più grandi registi non solo in vita ma di tutto la storia del cinema (americano e non): in 50 anni e rotti di carriera il regista newyorchese di nascita e siciliano di origine ha indelebilmente segnato (e cambiato) l’immaginario cinematografico, e arrivato alla veneranda età di 80 anni continua a realizzare opere di grande fascino, capaci ogni volta di aggiungere un tassello in più alla sua poetica, sempre in costante rinnovamento.
“Killers of the Flower Moon”, la sua ultima (si spera non definitiva) fatica, sceneggiato da Scorsese insieme ad Eric Roth (famoso per aver scritto “Forrest Gump“), è tratto da un saggio storico del giornalista David Grann del 2017, “Gli assassini della Terra Rossa: Affari, petrolio, omicidi e la nascita dell’FBI. Una storia di frontiera” (in originale “Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI“), che narra del massacro dei nativi americani dell’Osage, in Oklahoma, avvenuto negli anni Venti.
Gli Osage divennero la tribù nativa più ricca di tutte, a causa della scoperta del petrolio nella loro zona, ad Osage County, da cui trassero tutti i benefici legati alla sua vendita: ben presto però “l’uomo bianco” mise gli occhi addosso all’oro nero di quella terra, creando un piano crudelmente articolato per far fuori uno dopo l’altro i membri di quella tribù e impossessarsi dei loro profitti.
Il piano consisteva nello stabilirsi legittimamente ad Osage, cercando poi di integrarsi con i nativi, fino a tal punto da arrivare a sposare le figlie di ognuno dei capi tribù, per ottenere così da loro una sicura eredità dei proventi petroliferi: ma il vero obiettivo dell’ “uomo bianco” era in realtà quello di eliminare, tramite omicidi programmati e a lungo rimasti impuniti e senza colpevole, ognuno dei membri della tribù Osage nel corso degli anni, fino a divenire così gli esclusivi proprietari dei diritti petroliferi di quella zona.
La mente dietro questo programma criminale era William Hale,(nel film interpretato da un immenso Robert De Niro) allevatore di bestiame e politico, che si faceva chiamare dai suoi uomini con l’indicativo soprannome di “King“. Hale fu poi scoperto, processato e arrestato dall’FBI, che lo condannò all’ergastolo nel 1929, ma fu rilasciato di prigione nel 1947 per buona condotta (morì ad 87 anni nel 1962 in una casa di riposo).
Questa è una storia che parla di potere, della sua ricerca e soprattutto del suo mantenimento, di soldi (la diretta conseguenza del potere), di sangue e di malaffare (per conservare il potere bisogna pur sempre sporcarsi le mani), che ruotano tutte intorno alle origini di una Nazione, alla sua tumultuosa nascita e ancor di più al suo controverso sviluppo.
Tematiche ricorrenti nel cinema scorsesiano, da “Gangs of New York” (2002) a “Wolf of Wall Street” (2013), per non parlare di tutte pellicole aventi come nucleo centrale la mafia, da “Quei bravi ragazzi” (1990) sino al più recente “The Irishman” (2019). Tuttavia, rispetto alle precedenti opere menzionate, “Killers of the Flower Moon” è quella che più di tutte possiede il “messaggio politico” più rilevante, più sentito, ma che nonostante questo non tramuta mai in eccessiva retorica, non scavalcando negli intenti la narrazione: la Storia al servizio della poetica del suo Autore (ed il finale metacinematografico nel teatro ne è una chiara dimostrazione).
Non c’è però solo la violenza (più morale che fisica, visto che quest’ultima nel film è volutamente trattenuta nei suoi eccessi) del potere e dei soldi in “Killers of the Flower Moon“, ma tanto altro ancora, poichè si tratta pur sempre di un ampio racconto (quasi 3 ore e mezza di durata, tutte necessarie) dal respiro epico, e come tale concentrato su molteplici registri narrativi.
C’è infatti una grande storia d’amore, quella tra Ernest Burkhart (un altrettanto immenso Leonardo DiCaprio), il nipote di “King” Hale, nonchè complice delle sue malefatte, e l’indiana Mollie (Lily Gladstone, nel ruolo più importante della sua carriera): una storia d’amore difficile, tormentata (tra due culture così diverse non poteva essere altrimenti) eppure sincera e condivisa negli intenti (la coppia avrà tre figli, anche se uno morirà giovanissimo, fatto decisivo per lo sviluppo della storia verso il finale). C’è anche tanto melodramma insomma in questa pellicola, ma c’è sempre stato nella filmografia del regista italo-americano (da “New York New York” (1977) a “L’età dell’innocenza” (1993) per citare i più famosi).
Un po’western, un po’noir, un po’melò, con qualche tocco anche di commedia in alcuni dialoghi e situazioni: “Killers of the Flower Moon” non è facilmente ascrivibile ad un singolo genere, senza contare che anche la tematica spirituale/religiosa è ben presente. Basti solo menzionare le “premonizioni di morte” degli indiani (con la visione di un gufo come chiaro segnale di prossimo decesso) e i loro riti celebrativi come feste e matrimoni, sottolineati da Scorsese con la solita maniacale attenzione da “antropologo del cinema”: il recente “Silence” (2016), come anche “L’ultima tentazione di Cristo” (1988), sono abbastanza esplicativi al riguardo nel dimostrare quanto il regista newyorchese sia sensibile al tema.
Ritornando ai due personaggi principali dell’opera, Ernest Burkhart / Leonardo DiCaprio e William Hale / Robert De Niro, questi ultimi non sono affatto rappresentati come degli antieroi, ma come dei veri e propri villain: dei maniaci del controllo, che diventano subito paranoici appena qualcosa nel loro piano si inceppa o rischia di non funzionare, apparentemente sicuri di sè ma in realtà più fragili di quel che sembra. La loro caratterizzazione è volutamente esagerata in alcuni momenti, al limite del grottesco, venendo quasi ridicolizzati per la loro bassezza umana. E per entrambi non vi sarà alcuna redenzione, nonostante il pentimento finale di Burkhart che al processo per gli omicidi nella tribù Osage confesserà tutto, incastrando lo zio ma non riuscendo ad evitare l’ergastolo.
In definitiva, se non è comunque una delle sue opere migliori (nel senso che è “solamente” un film bellissimo, ma non un capolavoro, e di capolavori Scorsese ne ha fatti parecchi), “Killers of the Flower Moon”, nel panorama cinematografico contemporaneo, in cui i kolossal veri e propri (come questo) sono sempre più rari e i blockbuster ormai dominano incontrastati (e purtroppo sono sempre meno quelli di qualità), è ormai diventato un’ eccezione alla regola. Chi è che ormai ha ancora il coraggio ad Hollywood di realizzare pellicole così ambiziose (sia in ambito narrativo che produttivo)? Soltanto i grandi Autori, e Martin Scorsese, per nostra fortuna, è uno tra i pochi rimasti a crederci ancora, in questo tipo di cinema: o meglio, a credere ancora nel Cinema.